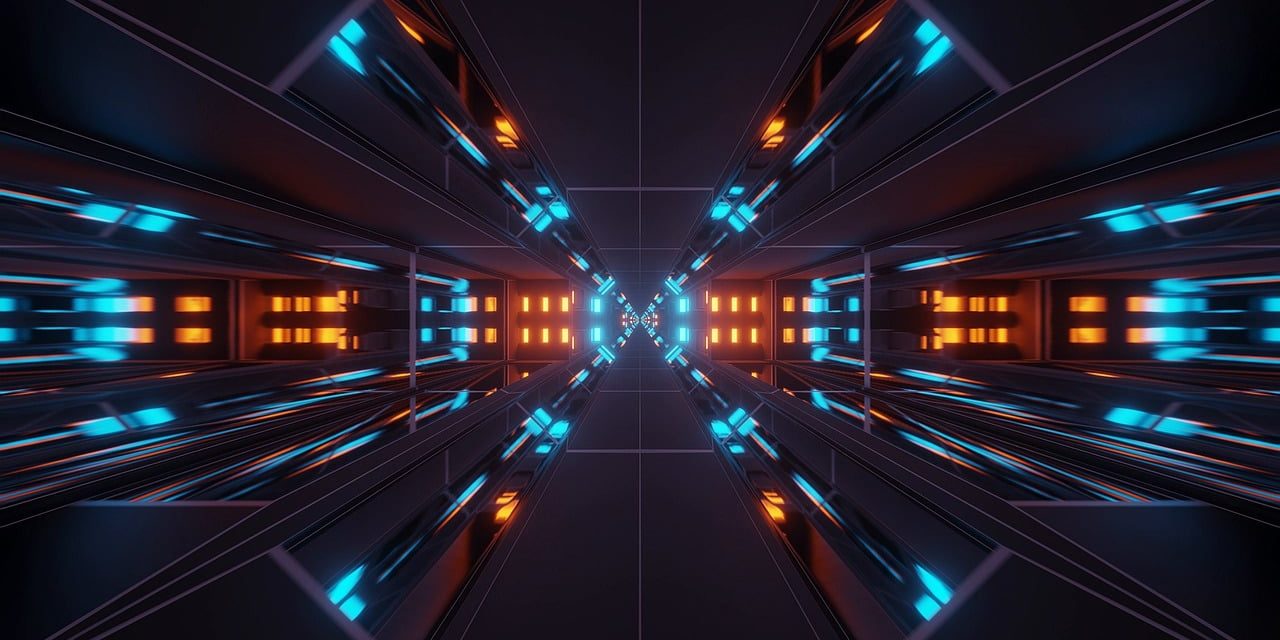“Il cambiamento del mondo non è soltanto creazione, progresso. Esso è prima di tutto e sempre decomposizione, crisi”. Alaine Touraine
In ogni sistema complesso, in ogni società, v’è una interconnessione tale per cui ciascuna sua parte si affida al funzionamento dell’insieme, ma dove ogni persona ha un proprio progetto esistenziale, anche se non è sempre capace di definirlo, decodificarlo, gestirlo, riscriverlo. Costruire una propria soggettività singolare esclude reiterazioni e automatismi, dipendenza dal passato e adesione al già dato, ma esclude anche opzioni per l’effimero e il banale, per lo pseudovalore e l’inautentico. All’opposto si reclama la fedeltà e l’impegno, il coraggio per i valori interiorizzati, l’esercizio della speranza e della lealtà, capacità di iniziativa e di autonomia, propensione al rischio e la passione per l’avventura, volontà di inseguire il permanente e di trascurare il precario. La conservazione e lo sviluppo dell’autoidentità chiedono l’intenzione di lasciarsi guidare da motivazioni intrinseche e di prendere le distanze da motivazioni generate esclusivamente da influenze estrinseche, che postulano una formazione incardinata sull’essere e non sull’avere, che esigono la padronanza del soggettivo decidere e agire reclamando la capacità gestionale della propria libertà, di andare oltre per raggiungere un proprio scopo autonomo. Progettare è pluralizzare e ampliare gli spazi del possibile, è decidere, è dare un significato e una direzione alle proprie azioni, è conferire tensione ideale alla propria esistenza, è far si che l’agire soggettivo sia un agire razionale, è rinunciare al disordine, all’incertezza, è rifiutare il sempre uguale e il già deciso, il preconfezionamento e il definitivo. Il progetto di vita si configura fonte primaria di identità. Questo non è più destino, bensì scelta e costruzione. Ad un’identità obbligata e necessitata la persona ha da opporre un’identità libera e creativa, intenzionale e progettuale, aperta e flessibile, processuale e dinamica, riflessiva e individuata, la quale rinviene la sua forza strutturante nella volontà di superamento di sé, nell’impegno a reinventarsi originalmente, nell’intenzione di ridurre soggettivi limiti e fragilità e di divenire personalità moralmente e socialmente apprezzabili.
Allorquando l’educazione culturale viene intesa come sviluppo o incremento di valore, l’abitudine è da escludere e da rigettare in quanto reiterazione, automatismo, dipendenza dal passato, o di adesione al già dato. Essa nega la pratica della libertà, non favorisce la disposizione alla criticità, alla creatività, non sollecita lo sperimentare inedito, nega la possibilità di orientamento culturale. L’inclusione globale è una visione che valorizza l’unicità di ogni persona e riconosce nei fatti, e non solo nelle azioni comunicative il valore determinante del talento umano come fattore insostituibile di successo, anche economico.
COSA SIGNIFICA PRODURRE E OFFRIRE CULTURA OGGI?
L’accessibilità in grado di favorire l’interazione, l’inclusione, l’intercettare di bisogni e tempi di vita della collettività propende verso un tipo di innovazione in grado di produrre valore sociale insieme al profitto individuale che permette di aprire porte per poter accedere in nuovi spazi in cui altri entreranno per aprire altre porte, stimolando la circolazione della conoscenza, rafforzando la collaborazione, l’intelligenza collettiva, riconoscendo lo stare bene insieme quale base caratterizzante dell’ecosistema. Inclusione e innovazione non sono mondi divisi. Le nuove idee nascono e si alimentano nei contesti più aperti ed accoglienti ma, a certe condizioni, dettati da spazi, strumenti e investimenti in conoscenza e innovazione che possono diventare fattori chiave per cambiare il destino di una comunità, città, … Qualsiasi punto di diversità può sviluppare una potenzialità culturalmente creativa e per creare una cultura inclusiva serve investire sulle buone ragioni del pluralismo creativo.
Le soluzioni ai problemi più complessi della ripresa richiedono che una vasta gamma di voci sia ascoltata, che proposte eterogenee siano prese in considerazione e che tutta la popolazione sia coinvolta nella ricostruzione. Poiché il talento è la chiave per il rilancio dei Paesi, loro imprese, allora dovrebbe essere riconosciuto ovunque si trovi e dovrebbe essere protetto e sviluppato in qualsiasi forma si presenti.
UNA TENDENZA, QUALE FUTURO?
L’innovazione culturale in senso ampio e l’affermarsi di nuovi trend in grado di produrre cambiamento richiedono di mettere in discussione regole, processi e linguaggi che si sono affermati in precedenza. Ad attivarsi su questa inclinazione orientativa sono soggetti nuovi che si costituiscono in imprese sociali che attivano collaborazioni con istituzioni culturali che ne integrano le competenze favorendo l’interdisciplinarietà, provando a costruire proposte e a valorizzarle per giocare un ruolo importante nella produzione e distribuzione culturale ma anche nella creazione di nuove economie e geografie urbane. È esattamente guardando a questa situazione di fermento e concentrazione unica che emerge la necessità di interrogarsi , attraverso un percorso di ricerca, su cosa significhi produrre e offrire cultura oggi, ed in particolare, fornire un quadro interpretativo su quali siano state e siano oggi le possibilità per farlo, quali le tipologie di governance e le modalità di funzionamento dei numerosi spazi multidisciplinari a vocazione culturale e artistica e quali possano diventare le traiettorie, le direzioni per il futuro e per la sostenibilità nel tempo. Ad imporsi è il riconsiderare un consolidato paradigma legato all’economia della cultura in una più ampia accezione di economia delle culture, valorizzando tutte le potenzialità rappresentate dai saperi, dalla dinamicità dell’umanità e da modalità alternative del fare cultura. Da non sottovalutare la dimensione fisico-spaziale ed i modi in cui la gestione dello spazio interno può influire su una declinazione attenta dell’offerta culturale, su condizioni di accessibilità in grado di favorire l’interazione, l’inclusione e intercettare bisogni e tempi di vita della collettività. Questa dimensione ha a che fare non solo con la progettazione vera e propria degli spazi, la loro ibridazione, apertura e flessibilità, ma anche con la relazione con il contesto urbano e la possibilità di coinvolgere target e comunità di un territorio e di creare sinergie o di rispondere a esigenze specifiche di quartiere.
L’esplosione di nuovi spazi risponde prima di tutto ad una chiamata dal basso con un pubblico che si allontana dal luogo deputato in favore di spazi nuovi e percepiti come più accessibili, meno lontani dalla quotidianità, poiché si avverte ad ampia scala, un bisogno di socialità e di riconoscimento con differenziate modalità di approccio al tempo libero ed al lavoro.
Il contemporaneo evolversi delle nuove tecnologie e della prassi di connessione costante stanno modificando profondamente le consuetudini, in un momento in cui il concetto stesso di condivisione non afferisce più, come un tempo, allo stare seduto con un altro spettatore in platea per assistere a ciò che accade, quanto a condividere quel momento con chiunque sia in grado di accedervi. Lo spazio deputato assume un nuovo tipo di dimensione e non è più legato ad una realtà materiale. L’abitudine alla velocità fa percepire come obsoleto qualsiasi luogo ove non sia possibile fare tante cose contemporaneamente, il tutto possibilmente in una cornice esteticamente interessante che rende rapido il processo di condivisione. Individuazione e valorizzazione di tutto ciò sono una sfida di interesse generale che a tutti i livelli deve essere messa all’opera per lasciare il segno e sancire la differenza per le future generazioni, per favorire lo sviluppo culturale-scientifico in un continuum costruttivo del BENE COMUNE quale risorsa da difendere e tutelare.
POST PRECEDENTE: CANCELLARE IDEE SUPERATE
POST A SEGUIRE: PRODUTTIVITÁ, INNOVAZIONE E PROGRESSO TECNOLOGICO